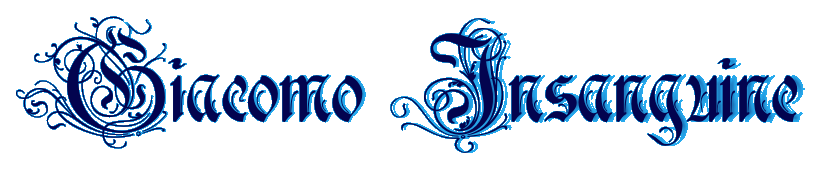|
Monopoli (Bari), 1728 - Napoli, 1795 Della sua numerosa famiglia, ben quattro sono i fratelli che si sono dedicati alle attività musicali: Francesco Paolo, il primo genito, Canonico e Maestro di Cappella della città di Monopoli; Giacinto, organista, e la sorella Giovanna Maria, come risulta dai Libri Capitolari dell’anno 1746 del Monastero dei Ss. Giuseppe ed Anna, in cui si legge “ in data 10 7bre del caduto anno 1745 attribuita la facoltà di poter ammettere alla vestizione e professione senza pagamento di dote la d.a Donzella Giovanna Maria Insanguine, purché la med.ma sia sufficientemente perita in suonare l’organo, accompagnare col suono med.mo quanto si cantano i Divini Officij, e Messa cantata con Canto Gregoriano…”. Ma soltanto Giacomo fu considerato promettente per affrontare studi più seri e quindi si recò a Napoli, dapprima presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, e successivamente presso quello di Sant’ Onofrio. Studiò con Girolamo Abos, Leonardo Leo e Francesco Durante, tra i massimi esponenti della cosiddetta “scuola napoletana” che, insieme a B. Storace, G. Strozzi, G. Greco (per citarne alcuni) e attraverso i quattro conservatori napoletani, ha dato il via ad una vera catena di maestri-allievi che ha contribuito allo sviluppo fiorente della musica tastieristica a cavallo tra seicento settecento. Insanguine fu anche Maestro di Cappella al Tesoro di S. Gennaro, carica questa molto ambita dai musicisti dell’epoca. I successi arrivarono con l’opera “Lo funnaco revotato” e “L’osteria di Marechiaro” che fu replicata per 60 sere consecutive. Questi ed altri successi non bastarono a proteggerlo dal malevolo giudizio che si era attirato a causa della pur evidente abilità di modificare ed integrare opere di altri compositori; noto è il sentimento di invidia provato dal tarantino G. Paisiello che gli attribuì l’appellativo sgradevole di “Maestro delle pezze”, appellativo, tra l’altro citato in tutti i dizionari. Gli fu affidata anche l’opera “Didone” di Baldassarre Galuppi perché l’accomodasse, ma lui invece la rifece completamente riscuotendo molto successo. La sua produzione musicale è fino ad ora rappresentata tutta da manoscritti inediti, custoditi per la maggior parte nella Biblioteca del Conservatorio di Napoli, ad eccezione della Sonata in Do maggiore per cembalo o organo. La Sonata è una breve composizione vivace, interessante per la finezza nell'abilità di scrittura. Questa Sonata è stata anche eseguita prima presso l'Associazione Clavicembalistica Bolognese, domenica 4 Maggio 2014, presso la Saletta della professoressa Maria Pia Jacoboni, nell'ottica di proporre ad ogni concerto una o più composizioni italiane o straniere inedite o di rara esecuzione. Per questa iniziativa tendente al rinnovamento dei repertori di musica da tasto si ringrazia non solo la clavicembalista Annalisa Ficarra e la professoressa, ma anche la disponibilità del Principe del Cembalo in termini di idee, progetti e partiture. Particolarmente degna di attenzione è la musica di ispirazione religiosa, dalla quale è tratto “In tam ferra et rea procella”, mottetto a voce sola di Soprano con strumenti del Sig. D. Giacomo Insanguine, detto Monopoli (iscrizione che compare nel primo foglio di ogni parte destinata ad ogni strumento), e “ Quoniam” a voce sola con oboe, tromba e fagotto obbligato (entrambe le composizioni sono state edite dalla casa editrice Vivere In di Monopoli, nel 1997 sempre a cura di M. Quarta). La casa editrice Armelin Musica di Padova ha edito nel 2012 “Benedictus” Canticum Zachariae per due Soprani e basso per l’organo con revisione e realizzazione del basso continuo a cura di M. Quarta.
|