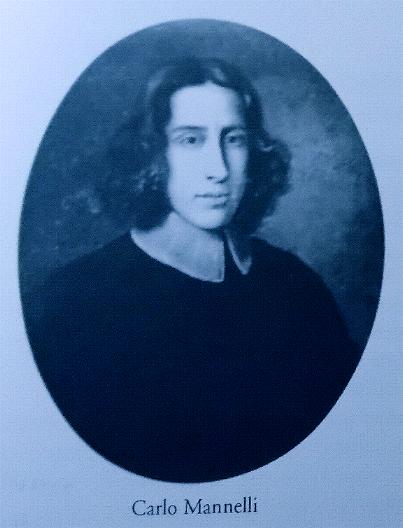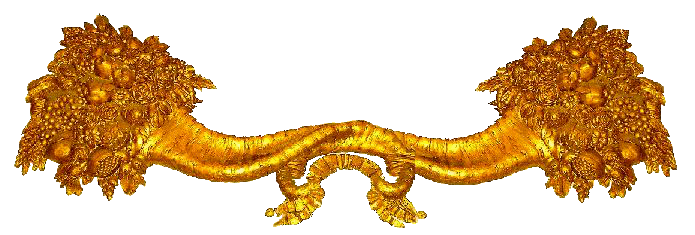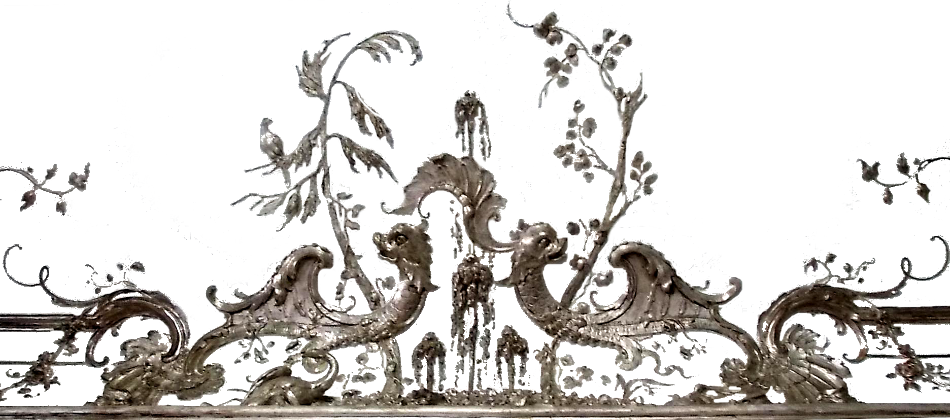

CANTORE
E MAESTRO DELLA CAPPELLA PONTIFICIA
ALLA
FINE DEL XVII SECOLO
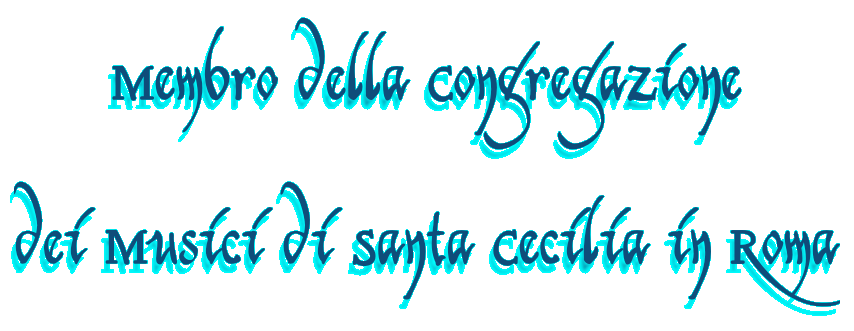
 Quando Don Gregorio de Giudici giunse a Roma, la città gli
apparve come uno straordinario scrigno di tesori di arte millenaria, nel
quale erano incastonati i migliori gioielli del rinnovamento urbanistico
promosso dai pontefici negli ultimi decenni. L’immagine dell’Urbe
che si spalancò dinnanzi agli occhi attoniti del giovane chierico
offriva una serie imponente di opere architettoniche, senza eguale al
mondo, fra cui si ergevano, accanto a ruderi dell’antichità classica,
i modelli più ammirati dell’arte costruttiva del momento, che
ispiravano un senso di vivissima sorpresa e di intensa emozione per
grandiosità, linee, colori e concezione spaziale. Proprio in quegli
anni, Bernini aveva completato il Colonnato di San Pietro, Francesco
Borromini lo strepitoso Sant’Ivo alla Sapienza e pittori del calibro
di Pietro da Cortona e Carlo Maratta, nobilitavano sale e cappelle con
affreschi ammiratissimi. Quando Don Gregorio de Giudici giunse a Roma, la città gli
apparve come uno straordinario scrigno di tesori di arte millenaria, nel
quale erano incastonati i migliori gioielli del rinnovamento urbanistico
promosso dai pontefici negli ultimi decenni. L’immagine dell’Urbe
che si spalancò dinnanzi agli occhi attoniti del giovane chierico
offriva una serie imponente di opere architettoniche, senza eguale al
mondo, fra cui si ergevano, accanto a ruderi dell’antichità classica,
i modelli più ammirati dell’arte costruttiva del momento, che
ispiravano un senso di vivissima sorpresa e di intensa emozione per
grandiosità, linee, colori e concezione spaziale. Proprio in quegli
anni, Bernini aveva completato il Colonnato di San Pietro, Francesco
Borromini lo strepitoso Sant’Ivo alla Sapienza e pittori del calibro
di Pietro da Cortona e Carlo Maratta, nobilitavano sale e cappelle con
affreschi ammiratissimi.
L’immagine della Roma pontificia tracciata da Sisto V con
l’apertura di nuove strade, piazze e monumentali palazzi era stata
ripresa e perfezionata dai suoi successori, Alessandro VII Chigi e
Clemente IX Rospigliosi, che avevano promosso grandiose opere di
incredibile suggestione, simboli del potere pontificio, capaci di
dettare legge in Europa per oltre due secoli.
Roma era meta di schiere di letterati, pittori, artisti,
musicisti, viaggiatori e attori, che convenivano da ogni parte
d’Europa.

Con regolari cadenze ed in occasione di particolari
cerimonie, fioriva una serie impressionante di celebrazioni con musiche,
cori, luci, decorazioni, scenografie e grandi apparati nei luoghi sacri,
negli oratori e nei palazzi nobiliari e degli ambasciatori stranieri.
Come centro mondiale della Cristianità, la Roma papale aveva
accentuato, anche per mezzo di cerimonie ed apparati fastosissimi, quel
sincero rinnovamento religioso e spirituale promosso dal sacrosanto
Concilio di Trento. Sede del Sommo Pontefice, la città era divenuta un
centro ineguagliabile di committenza artistica in cui facevano a gara
fra loro i cardinal-nepoti, gli alti prelati, i nobili romani e
stranieri, le confraternite e le numerose fiorenti istituzioni
religiose.
 Un aspetto fondamentale caratterizzava la
religiosità barocca:
la Chiesa militante celebrava la Gloria del Signore ed il suo splendore
incomparabile, attraverso l’opulenza dei materiali e delle forme,
esaltando la Fede e la Religione per mezzo dei migliori aspetti
sensibili che alludevano e preludevano, in terra, a quelli spirituali ed
ultraterreni della beatitudine celeste. All’interno delle chiese,
l’arte barocca celebrava i suoi suggestivi trionfi: dorature, stucchi,
drappi di stoffa pregiata, panneggi, marmi policromi, pitture e
sculture, tutto convergeva verso l’Altare, sul quale la Chiesa offriva
il Santo Sacrificio della Messa. Il fasto echeggiava anche nelle
facciate esterne delle chiese, popolate da un susseguirsi di statue di
santi, cornici, capitelli, colonne, stemmi ed emblemi. Alla straordinaria e memorabile attività culturale che
contrassegnò la seconda metà del XVII secolo a Roma, diede un impulso
notevole la Regina Cristina di
Svezia, convertitasi alla vera fede e
stabilitasi nella Città Eterna fin dal 1655, accogliendo nel Palazzo
Riario, sede della sua residenza, numerosi intellettuali, letterati,
scienziati e musicisti (come Bernardo Pasquini,
Alessandro Stradella ed
in seguito Arcangelo Corelli ed
Alessandro
Scarlatti). La Regina
Cristina promosse rappresentazioni, concerti, accademie culturali,
cerimonie ed eventi festivi, in cui veniva accentuata al massimo la
meraviglia e l’effimera bellezza delle forme e la caducità delle
cose. L’idealizzazione classica con ninfe, muse e pastori, ispirata ai
miti greci, portò, nel 1690, alla fondazione dell’Arcadia, un
nuovo e prestigioso sodalizio letterario ed artistico che influenzerà
il gusto dell’Europa intera. Un aspetto fondamentale caratterizzava la
religiosità barocca:
la Chiesa militante celebrava la Gloria del Signore ed il suo splendore
incomparabile, attraverso l’opulenza dei materiali e delle forme,
esaltando la Fede e la Religione per mezzo dei migliori aspetti
sensibili che alludevano e preludevano, in terra, a quelli spirituali ed
ultraterreni della beatitudine celeste. All’interno delle chiese,
l’arte barocca celebrava i suoi suggestivi trionfi: dorature, stucchi,
drappi di stoffa pregiata, panneggi, marmi policromi, pitture e
sculture, tutto convergeva verso l’Altare, sul quale la Chiesa offriva
il Santo Sacrificio della Messa. Il fasto echeggiava anche nelle
facciate esterne delle chiese, popolate da un susseguirsi di statue di
santi, cornici, capitelli, colonne, stemmi ed emblemi. Alla straordinaria e memorabile attività culturale che
contrassegnò la seconda metà del XVII secolo a Roma, diede un impulso
notevole la Regina Cristina di
Svezia, convertitasi alla vera fede e
stabilitasi nella Città Eterna fin dal 1655, accogliendo nel Palazzo
Riario, sede della sua residenza, numerosi intellettuali, letterati,
scienziati e musicisti (come Bernardo Pasquini,
Alessandro Stradella ed
in seguito Arcangelo Corelli ed
Alessandro
Scarlatti). La Regina
Cristina promosse rappresentazioni, concerti, accademie culturali,
cerimonie ed eventi festivi, in cui veniva accentuata al massimo la
meraviglia e l’effimera bellezza delle forme e la caducità delle
cose. L’idealizzazione classica con ninfe, muse e pastori, ispirata ai
miti greci, portò, nel 1690, alla fondazione dell’Arcadia, un
nuovo e prestigioso sodalizio letterario ed artistico che influenzerà
il gusto dell’Europa intera.
Fra i mecenati che si susseguirono negli anni di presenza di Don
Gregorio a Roma ebbero maggior luce i cardinali Benedetto Pamphili
e
Pietro Ottoboni. Il primo fu rinomato per le accademie domenicali che
riuniva  nel suo Palazzo al Corso, in cui venivano rappresentate
importanti composizioni e gli Oratori per i quali egli stesso scriveva
il libretto. Con l’elezione di Alessandro VIII Ottoboni, avvenuta
nell’ottobre 1689, il pronipote del Papa, il giovanissimo Card. Pietro
Ottoboni, inaugurò un eccezionale periodo di mecenatismo artistico e
musicale, che lo fece salutare come uno dei più grandi mecenati di
tutti i tempi. Con una vastità di interessi culturali e musicali di
certo non comuni, il Card. Ottoboni promosse una serie di eventi
musicali di genere sacro e profano con il concorso dei migliori
musicisti, fra cui le celebrazioni nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso,
le Cantate per la Notte di Natale nel Palazzo Apostolico, alla presenza
del Papa e dei cardinali, numerosi oratori, cantate e sonate da camera,
eseguite nel suo Palazzo della Cancelleria, a cui guardavano con
ammirazione i musici di tutta l’Europa. nel suo Palazzo al Corso, in cui venivano rappresentate
importanti composizioni e gli Oratori per i quali egli stesso scriveva
il libretto. Con l’elezione di Alessandro VIII Ottoboni, avvenuta
nell’ottobre 1689, il pronipote del Papa, il giovanissimo Card. Pietro
Ottoboni, inaugurò un eccezionale periodo di mecenatismo artistico e
musicale, che lo fece salutare come uno dei più grandi mecenati di
tutti i tempi. Con una vastità di interessi culturali e musicali di
certo non comuni, il Card. Ottoboni promosse una serie di eventi
musicali di genere sacro e profano con il concorso dei migliori
musicisti, fra cui le celebrazioni nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso,
le Cantate per la Notte di Natale nel Palazzo Apostolico, alla presenza
del Papa e dei cardinali, numerosi oratori, cantate e sonate da camera,
eseguite nel suo Palazzo della Cancelleria, a cui guardavano con
ammirazione i musici di tutta l’Europa.
Fra
i musicisti che operarono alla corte del Pamphili e poi dell’Ottoboni
ricordiamo innanzitutto Arcangelo Corelli, geniale violinista e
compositore fra i più grandi di tutta la Storia della Musica, membro
dell’Arcadia e vera autorità musicale della Roma di fine seicento.
Grande
stima godette anche Bernardo Pasquini
(qui per
ascoltare alcuni brani al Cembalo eseguiti live da Paola Nicoli Aldini), uno dei maggiori cembalisti e
organisti del secolo, che brillava per le sue improvvisazioni, con cui
sbalordiva gli ascoltatori. Verso il 1670, Pasquini divenne Maestro di
Cappella del Principe Giambattista Borghese, poi della Regina Cristina e
membro infine dell’Arcadia. Giacomo Carissimi, considerato ed ammirato
come il padre della forma moderna dell’Oratorio, Maestro di Cappella
della Chiesa di Sant’Apollinare del Collegio Germanico-Ungarico dei
Padri Gesuiti, portò a grande perfezione il genere oratoriale, in cui
la varietà drammatica era sostenuta da un accuratissimo accompagnamento
orchestrale.
Come
compositore di musica sacra si impose Giuseppe Ottavio Pitoni, Maestro
di Cappella fra i più celebrati dell’epoca, autore di un numero
immenso di messe, mottetti, antifone e salmi, che concluse la sua
carriera musicale come Maestro della Cappella Giulia in Vaticano e venne
sepolto nella Chiesa di San Marco.
Molti
musicisti di assoluto talento del periodo barocco soggiornarono a Roma,
dove iniziarono la loro parabola ascendente, propagando la loro
influenza in tutta l’Europa. Fra i compositori che si formarono a Roma
e vi dimorarono per un certo tempo, ricordiamo Alessandro Scarlatti,
giuntovi a soli dodici anni, che fin dalla sua prima giovinezza operò
con successo nell’ambiente musicale romano, presentando la sua prima
opera nel 1679, a diciannove anni, sotto la protezione della Regina
Cristina di Svezia e del Cardinal Pamphili.
 Ugualmente,
il giovanissimo musicista modenese Antonio Maria Bononcini fu presente a
Roma negli ultimi anni di residenza di Don Gregorio de’ Giudici,
facendosi ammirare per le proprie geniali qualità di violoncellista e
compositore. Ugualmente,
il giovanissimo musicista modenese Antonio Maria Bononcini fu presente a
Roma negli ultimi anni di residenza di Don Gregorio de’ Giudici,
facendosi ammirare per le proprie geniali qualità di violoncellista e
compositore.
Negli
anni cruciali per l’affermazione dell’arte musicale barocca, con il
rinnovamento dei gusti, degli stili, tecniche e pratiche musicali e
l’emancipazione dai vincoli polifonici, l’ambiente romano fu
estremamente idoneo all’affermarsi di iniziative musicali che
impegnavano una folta schiera di protettori e mecenati, esecutori,
editori e tipografi nel genere sacro e profano, nell’intento di
superare con fervida fantasia, i canoni del classicismo rinascimentale.
Proprio a Roma si dispiegò l’opera di numerosi artisti di prima
grandezza, verso le nuove conquiste estetiche del melodramma e della
musica strumentale che iniziarono a definirsi con una propria ed
acclamata dignità artistica.
In
questo particolare momento, assunse un ruolo di primissimo piano la
Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, un organismo a statuto
pontificio ordinario, riconosciuto ed approvato con vari documenti
papali, fra cui una Bolla di Papa Sisto V ed un Breve di Urbano VIII (1).
Queste
disposizioni apostoliche simili a quelle emanate in occasione della
costituzione di nuovi ordini religiosi, istituti, collegi e
confraternite, assegnavano al sodalizio ceciliano dei compiti molto
prestigiosi nel panorama artistico e culturale della Città Eterna. Le
cerimonie musicali negli appuntamenti prestabiliti per statuto nel suo
calendario liturgico e l’assistenza sociale dei musici confratelli
infermi o indigenti, ne fecero un eccellente istituto di arte musicale e
di provvida assistenza benefica.
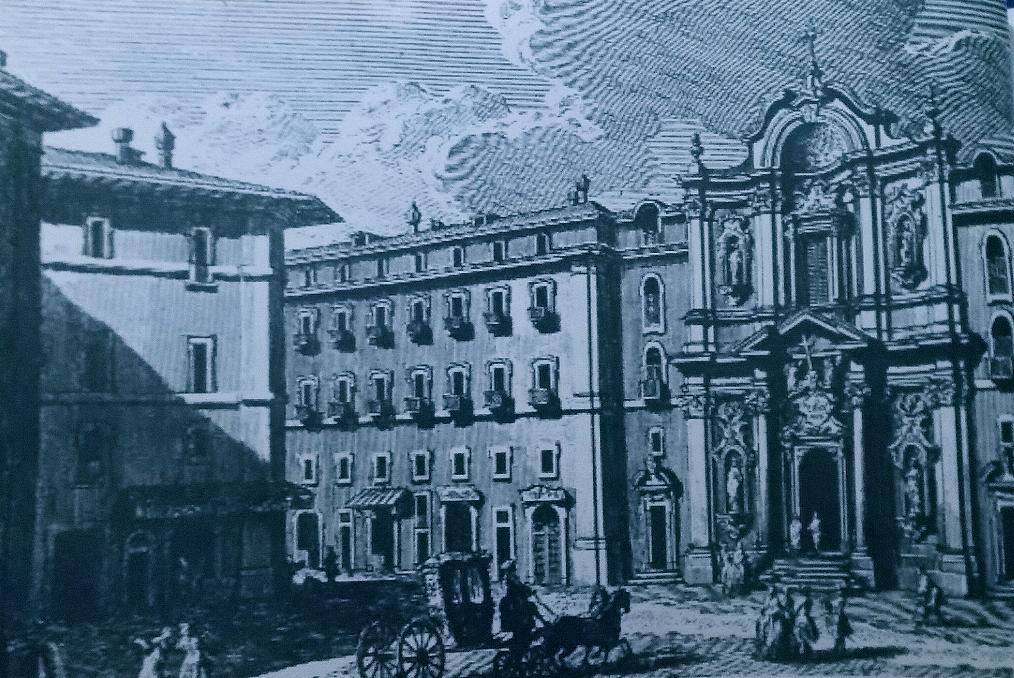
Alla
metà del XVII secolo, i membri della Congregazione erano interpellati
dall’alto patriziato romano per gli interventi musicali in occasioni
festive e celebrative, fornendo strumentisti, musici, cantori e
organisti di primissima scelta e svolgendo una assidua vigilanza nei
settori della vita musicale pubblica romana. Proprio in quegli anni,
l’attività dei Barberini e dei Rospigliosi nell’organizzazione
degli spettacoli musicali, consentì alla Città di Roma di assumere una
posizione di assoluta preminenza nel panorama del teatro musicale
dell’epoca.
La
Congregazione dei Musici di Santa Cecilia aveva una struttura interna
precisamente definita nelle cariche onorarie ed effettive. Il Cardinale
Protettore conferiva prestigio, lustro e protezione al sodalizio in
tutte le sue difficoltà, mentre il Prelato Primicerio assumeva
le vere funzioni di presidente dell’istituzione. Accanto a queste
figure si affiancavano, per i compiti pratici ed organizzativi, i “Guardiani”,
presidenti delle varie categorie dei congregati: maestri di cappella,
strumentisti, cantanti (musici) e organisti. Il Camerlengo era il
tesoriere e responsabile amministrativo, affiancato dal Segretario.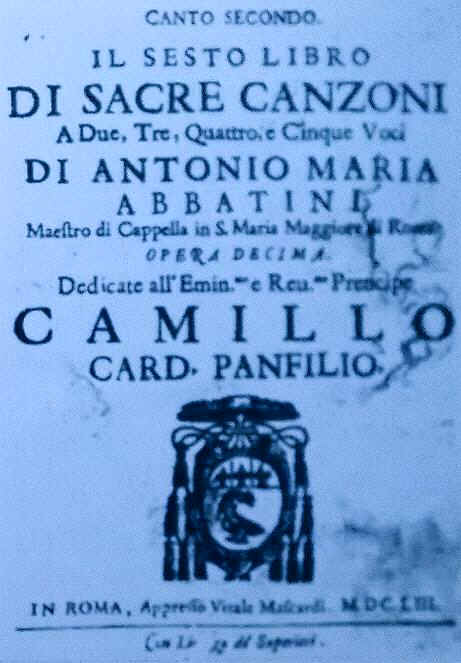
Molta
importanza rivestivano le cariche di Infermiere e Visitatore
delle Carceri, impegnati scrupolosamente nelle pratiche
assistenziali in favore dei congregati, che costituivano una parte
ammirevole dell’attività del sodalizio ceciliano.
I
Verbali di due sedute della Congregazione dei Musici di Santa Cecilia
documentano l’aggregazione del sacerdote e musico ceccanese Don
Gregorio de Giudici all’insigne istituzione romana e, nel contempo,
offrono uno squarcio di luce sulla sua biografia artistica e sulla sua
personalità umana.
Egli
risultava aggregato al sodalizio ceciliano nella categoria degli
esercenti, come musico cantore che svolgeva stabilmente ed ufficialmente
una apprezzata attività artistica nelle cappelle e basiliche romane.
In
ogni caso, i dati su Don Gregorio che si ricavano dalle due sedute,
hanno valore retrospettivo e ci inducono a ritenere che il giovane
cantore facesse parte del sodalizio già da qualche tempo, figurando fra
i congregati intervenuti alle riunioni nella categoria degli artisti che
godevano di una posizione sociale e di una affermazione artistica
riconosciuta professionalmente.
Nel
caleidoscopico e fervido ambiente musicale romano, Don Gregorio era una
personalità musicale già in vista ed un serio professionista, che
svolgeva la sua attività in posizioni di prestigio e con una precisa
vocazione musicale. Certamente, egli si sentiva molto fiero del grande
privilegio che gli veniva concesso di appartenere alla
istituzione, considerandosi quasi insignito di una preziosa
onorificenza artistica.
La
prima seduta in cui figura il nome di Don Gregorio de Giudici si tenne
il 18 marzo 1664, nella Chiesa di  Santa Maria Maddalena, presso i Padri
Ministri degli Infermi di San Camillo de Lellis (2). In quella
occasione, la Congregazione Generale composta da ben 48 membri, venne
chiamata ad eleggere i nuovi Officiali, cioè i quattro Guardiani,
il Camerlengo, il Segretario, i Sindici e gli Infermieri.
Nel corso delle votazioni, fu confermato Guardiano dei Maestri di
Cappella Antonio Maria Abbatini, mentre per l’ufficio di Guardiano
degli Organisti, si fronteggiarono varie candidature fra cui quella
di Ercole Bernabei e Arcangelo Lori. Santa Maria Maddalena, presso i Padri
Ministri degli Infermi di San Camillo de Lellis (2). In quella
occasione, la Congregazione Generale composta da ben 48 membri, venne
chiamata ad eleggere i nuovi Officiali, cioè i quattro Guardiani,
il Camerlengo, il Segretario, i Sindici e gli Infermieri.
Nel corso delle votazioni, fu confermato Guardiano dei Maestri di
Cappella Antonio Maria Abbatini, mentre per l’ufficio di Guardiano
degli Organisti, si fronteggiarono varie candidature fra cui quella
di Ercole Bernabei e Arcangelo Lori.
Il
Verbale della seduta costituisce un documento di grande importanza
storica, nel quale Don Gregorio risulta a diretto contatto su un piano
non solo artistico, ma anche umano e sociale, con alcune personalità
del mondo musicale romano di assoluto rilievo ed estremamente influenti,
come Antonio Maria Abbatini, Francesco Foggia, il celebre violinista
Carlo Mannelli ed il cantore Francesco Litrico. Questi personaggi, con
intenti di sincera fraternità e spirito di collaborazione,
partecipavano all’attività di un sodalizio che preparava, in quegli
anni, una nuova epoca per l’arte musicale, scenica, vocale e
strumentale romana, promovendo, nello stesso tempo, una serie ammirevole
di iniziative di carità.
Il nome di Don Gregorio è nuovamente citato nel Primo Volume dei “Verbali
delle Congregazioni Generali e Segrete”, in data 22 ottobre 1669
fra i partecipanti alla Congregazione che si riunì sotto la presidenza
del Primicerio, Mons. Girolamo Casanate, celebre letterato e futuro
cardinale (3). Nella seduta vennero assunte delle importanti decisioni
in ordine alla organizzazione di grandi celebrazioni musicali per
l’imminente festa di Santa Cecilia.
Come
attestano i due verbali, in queste sedute della Congregazione vennero
trattati problemi di particolare natura e di significativa portata,
relativi ai domini dell’arte e dell’assistenza sociale, a conferma
dell’importanza dei compiti assunti dal sodalizio ceciliano negli anni
del rinnovamento culturale e musicale della società romana, che
caratterizzarono la seconda metà del XVII secolo.
|

1)
Sulla Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, si veda REMO GIAZOTTO, Quattro
secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 voll.,
Roma 1970. Per uno sguardo d’insieme sul periodo romano negli anni di
Arcangelo Corelli, si veda lo Speciale Amadeus su Arcangelo Corelli,
De Agostini – Rizzoli Periodici, Milano 1998, con articoli di Massimo
Rolando Zegna, Gloria Staffieri e Carlo Vitali.
2)
Archivio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Verbali delle
Congregazioni Generali e Segrete, Volume I, cc. 41 r et v. Nei
registri del sodalizio, la posizione di Don Gregorio de Giudici come
congregato è la numero 299.
3) Ibidem, cc. 21 r et v.
|
La
Triade Barocca (Haendel.it - handelforever.com e GFHbaroque.it)
ringrazia infinitamente l'avv. Stefano Gizzi per la disponibilità e la
concessione di condividere con tutti gli appassionati squarci
dettagliatissimi del periodo barocco, che ruotarono attorno alla figura
di Don Gregorio de Giudici
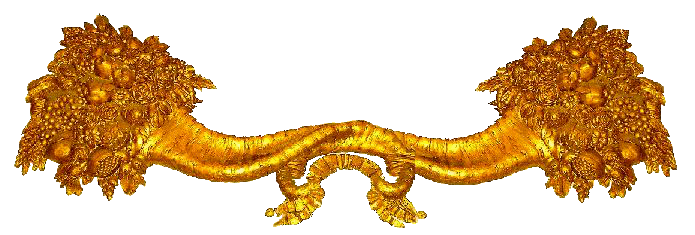
Torna
all'Index di Don Gregorio De Giudici
A
cura di
Il
Principe del Cembalo - Rodelinda da Versailles
Arsace
da Versailles - Faustina da Versailles
Arbace
- Alessandro - Andrea - Carla
Stefano
Gizzi
Torna
alla Home di Versailles
Vai
a Versailles en clavecin
Torna
alla Home
Vai
a GFHbaroque.it

|
![]()
![]()